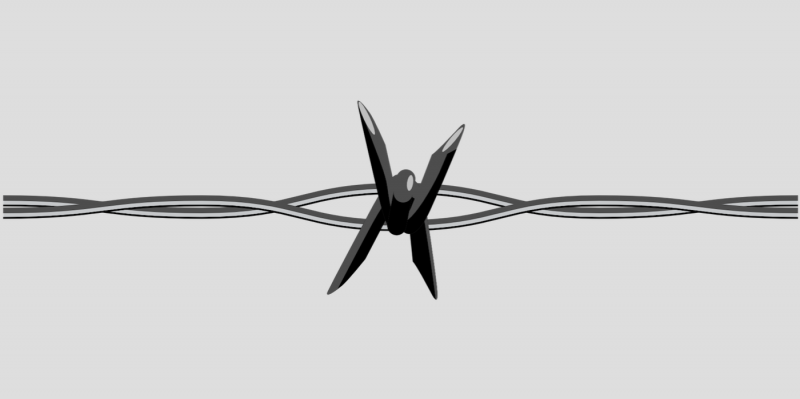Questo è il quarto episodio della serie “Sonno o morte”, nella quale l'attivista Sarmad Al Jilane racconta le sue esperienze in una prigione siriana. Qui potete leggere la prima [it], la seconda [it] e la terza parte [it].
Nonostante tutto ciò che abbiamo dovuto passare nelle scorse settimane, nonostante le botte, le torture, l'asportazione delle unghie, nonostante la corrente che ci pervade come i cavi elettrici di questa prigione, alcuni di noi hanno ancora abbastanza forza per ribellarsi contro i loro aguzzini.
L'ottavo giorno tirano fuori dalle celle me, Abdul Rahman e molti altri prigionieri. L'inquirente tiene dei fogli di carta contro la parete e ci dà una penna: “Forza, firmate”. Cerco di capire il contenuto del testo scritto a mano, per quanto possibile. Sembra che si tratti del rapporto sull'interrogatorio. Un paio di schiaffi e di botte con la sbarra di metallo che tiene in mano mi impediscono di capirci di più. “Ho detto di firmare, non di leggere, cane”. Tra altre offese firmo, firmiamo tutti, e poi torniamo nella nostra cella e aspettiamo.
Non siamo né afghani, né terroristi. Nessuno di noi sa come installare una esplosivo improvvisato, e nessuno di noi ha proclamato la sacra Jihad; ai nostri occhi la rivoluzione significa libertà. Non abbiamo incolpato nessuno per l'abbandono della fede; non abbiamo intenzione di purificare il mondo. Non siamo assassini, non abbiamo ferito nessuno. Il nostro unico crimine è stato pensare ad alta voce ed esprimere le nostre richieste in modo forte e chiaro.
I giorni passano; dipendiamo dal nostro calendario particolare e improvvisato. Una striscia verso il basso per ogni giorno che viene e va, e il quinto giorno una striscia orizzontale di traverso sopra le altre quattro. I giorni in cui liberano uno di noi li segniamo con dei cerchietti. Ma questo calendario non è il migliore per persone come me, che migrano da una prigione all'altra direttamente, siccome si lasciano le strisce e il sangue sui muri.
Arriva la guardia. Dopo aver ordinato ad Abdul Rahman di raccogliere le sue cose, lo porta con sé. Gli diamo messaggi per i nostri cari e lui cerca di ricordarsi quanti più numeri di telefono possibili per dare un po’ di speranza alle nostre famiglie. Se ne vanno e io rimango qui, ormai solo tra altre trentasette anime sole.
E poi, molto tempo dopo, arriva il giorno agognato, il giorno in cui il mio nome non si trova sulla lista che la guardia legge ad alta voce. “Sarmad, prendi le tue cose e vieni con me”. Non mi copre la testa, né mi ammanetta. La mia gioia mi fa quasi dimenticare i numeri che dovrei ricordare per i miei compagni di cella. Entriamo nel cortile. Cominciano i soliti rituali di saluto, ma questa volta è un addio. Mettono i nostri oggetti di valore in sacchi e ci legano ad una lunga catena. Sento il cuore battermi nelle piante dei piedi. “La catena per Damasco è pronta, portatela alla porta. Saranno trasferiti lì dopo due giorni alla caserma della polizia militare”, dice una guardia piena di orgoglio. Si sistema il suo berretto rosso mentre tutti noi saliamo sull'autobus.
Lasciamo la prigione. Riesco a vedere la casa dei miei nonni, ci passiamo proprio davanti! Alcune città incarnano la tragedia che la storia della nostra vita rappresenta; già dall'origine del mondo il nostro destino è scolpito nella pietra e l'oasi della nostra infanzia e della nostra giovinezza si trasforma nel macello dove veniamo sacrificati. La rivoluzione pesa sulle mie spalle, mentre dall'autobus vedo casa mia passarmi davanti agli occhi, a un paio di metri da noi, eppure così distante da questo mondo di tirannia. Io e casa mia, separati da un intero regime, come se un ragazzo giovane, appena diventato maggiorenne, fosse colpevole per tutto quello che è successo al nostro Paese. In quel momento comincio a piangere per la prima volta.
Entriamo nella caserma della polizia militare di Deir ez-Zor. Scendiamo dall'autobus e ci raccogliamo intorno ad una piccola macchia d'erba in cortile. Otto guardie siedono lì, ognuna con una frusta in mano. Pneumatici di tutte le dimensioni sono sparse sul terreno. Una guardia prende i nostri documenti e le nostre cose e le altre ci conducono all'interno. Ci tolgono le catene. Ogni guardia acciuffa uno di noi e uno pneumatico adeguato. E poi comincia la “gommatura”; così chiamano quello che ci stanno per fare.
La mia guardia mi infila in uno pneumatico, mi spinge a terra e comincia a picchiarmi. Non la smette finché non vede sangue; il che non richiede meno di quindici colpi. Ci portano nella prigione, costituita da un bagno grande e tre unità enormi collegate da un grande atrio al centro. Le voci dei prigionieri si fanno più forti. “Tra un paio d'ore verrà servito il pranzo; qualche desiderio?”. Siamo sorpresi di scoprire che qui si possono pagare le guardie per farsi portare ciò che si desidera. Tuttavia, i nostri averi sono nelle borse che ci hanno confiscato, quindi che senso ha? Il pranzo viene servito e in presenza degli altri ospiti interrompiamo finalmente la nostra dieta di bulgur, patate e ossa di pollo.
Poi fissano delle visite. Uno dei prigionieri conosce mio zio, e quando sua moglie viene a trovarlo la prega di chiamare i miei genitori. Lo fa, e dopo un'ora arriva una guardia con quindicimila lire siriane e un fagotto di vestiti che mi stanno troppo grandi, o che forse mi stavano ancora prima di essere imprigionato. E sia; l'importante è che mi tolga un po’ di nervoso e di tensione. E, cosa ancora più importante: i vestiti nuovi mi tolgono dalle spalle il peso di dover fare attenzione alla giacca blu, che ho nascosto con cautela sotto la mia felpa.
“Questo è per te. Non hai il permesso di ricevere visite, te lo ha portato qualcuno”. Ho scoperto solo molto più tardi, cioè dopo la mia liberazione, che era stato Aghyad a portarmi quelle cose. La guardia si era rifiutata di farlo entrare e gli aveva chiesto mille lire per portarmi quelle cose. Qui controllano l'identità di ogni singolo visitatore; se avessero lasciato entrare Aghyad, non ne sarebbe uscito vivo. È ricercato, e l'inquirente aveva dimostrato un interesse particolare per lui durante l'interrogatorio.
Torniamo di nuovo dentro. Io indosso i miei vestiti nuovi. Mi siedo e aspetto di essere trasferito. Passano due giorni; il terzo veniamo trasferiti nel distretto di sicurezza militare di Raqqa. Si svolgono gli stessi rituali; anche loro sono stati indottrinati con la scelleratezza del partito Ba'th. Dopo altri due giorni arriviamo ad Aleppo; per essere più precisi, alla caserma della polizia militare ad Al-Jmaylie. È stata l'ultima volta in cui ho visto Aleppo. Lancio uno sguardo dal finestrino dell'autobus mentre mi spingono la testa tra le gambe. È un momento di trionfo, quello sguardo verso le persone, verso le strade, dopo aver passato tanti giorni a desiderarlo. Mi aveva colpito soprattutto il bar Al-Yamani, e quel nome mi è ancora impresso nella mente adesso, quattro anni dopo.
Arriviamo alla caserma della polizia militare. Ci coprono la testa e ci tolgono le catene. Entriamo nell'edificio. Siamo quaranta in una stanza. “Mettetevi tutti al muro e spogliatevi, eseguiamo due misure di sicurezza. Veloci!”, latra una guardia mentre ci scopre le teste. È magro, non più alto di un metro e settanta, e ha un bastone nero in mano che è lungo quasi quanto la sua gamba. Siamo nudi fino alle ossa e non ci muoviamo mentre ci scruta. È la prima volta che veniamo abusati sessualmente. Passa con il bastone sopra i nostri genitali e sopra i nostri sederi, a volte li tocca in modo provocatorio. Abusa di ognuno di noi, come se volesse vendicarsi di un qualche tipo di demone. Devono aver considerato i nostri canti di libertà una sorta di stupro, e adesso hanno l'occasione di vendicarsi.
Al suo comando ci rivestiamo. Ci ridanno i nostri soldi, ma non la borsa con le nostre cose di valore. Poi veniamo suddivisi nelle nostre celle, dove troviamo tè, sigarette e tutti i possibili oggetti proibiti. Dopo aver creduto per tutto questo tempo nel sogno in cui un singolo sorso di tè e un tiro di sigaretta Alhambra possono svegliarti e riportarti in vita. Nonostante siamo solo in sette, chiediamo un bricco di tè da cinque litri, oltre a sigarette e una grande quantità di cibo. Qui funziona così: si chiedono cibo e tutte tutte quelle cose quotidiane e senza senso che in realtà appartengono ai diritti fondamentali di ogni persona, e poi si ringrazia perché ti portano le cose che hai pagato con i tuoi soldi. E tutto questo mentre sei rinchiuso e torturato. Siccome ho le scarpe da ginnastica, sfrutto l'occasione e nascondo attentamente una sigaretta sotto la suola; ci tornerò più tardi.
I due giorni seguenti passano velocemente. Poi veniamo trasferiti di nuovo. La stessa stanza gigantesca. Ci legano tutti ad una catena. C'è anche Taher! Sta litigando con una guardia, le loro voci diventano man mano più forti. “Ti ho detto che ero il capo del mio clan, e né tu né nessun altro potete cambiarlo. Slegami e portami all'inizio della fila!”. Taher strilla, senza curarsi minimamente di ciò che gli sta intorno. Dopo una lunga discussione la guardia lo slega e lo incatena di nuovo all'inizio della fila.
Il colonnello dietro al tavolo comincia a timbrare i documenti per il trasferimento. Taher si muove lento in avanti (tutti gli sguardi sono rivolti a lui), prende alcuni sacchetti in cui si trovano delle forme di pane dall'armadio vicino al colonnello e comincia a dividerle tra i prigionieri. Il colonnello lo rimprovera per questo. “Mio signore, non riesco a svegliarmi se non mangio qualcosa, e sai che non posso mangiare mentre gli altri mi guardano. Perciò ho pensato che fosse meglio dare un pezzo di pane anche a questi poveri uomini”. Per quanto si impegni ad assumere un'espressione seria, quando parla, Taher ha sempre un sorriso sul volto. Una guardia lo picchia fino a farlo cadere a terra.
Taher aspetta che la guardia se ne vada, poi si tira su a fatica e si siede sulla sedia di metallo vicino al tavolo. Il colonnello alza lo sguardo e cerca di nascondere la sua ira. Una guardia accorre per colpire di nuovo Taher. “Mio signore, non siamo tutti figli del nostro signor Presidente, il nostro capo? Puoi conciliare il tuo cuore con l'idea che a tuo fratello, nato nel tuo stesso Paese, sotto lo stesso capo, non è permesso riposarsi un po’ su questa sedia?”. Il colonnello scoppia a ridere quando sente le parole di Taher, e mette via il suo timbro.
Ci portano nel cortile. Ci aspettavamo di vedere un autobus, invece troviamo un camion che sembra un furgone per il trasporto delle verdure. Ci spingiamo sulla fredda superficie per il carico nel retro della vettura. Novantatré uomini, stretti come sardine sott'olio in un barattolo. Un amico mi mostra come si allentano le manette, perché il viaggio è lungo. Nessuno parla. Regnano silenzio e paura di quello che succederà.